
Le scritture del codice degli abbozzi di Petrarca e la sua fortuna
Marco Cursi & Carlo Pulsoni
Il ‘codice degli abbozzi’ Vat.lat. 3196 ha costituito il campo d’indagine privilegiato per diversi tentativi di ricostruzione dello svolgimento dei processi di genesi, trasformazione e fissazione del testo poetico nell’officina scrittoria di Francesco Petrarca. Nella prima parte della comunicazione verranno proposte alcune considerazioni sulle pratiche di composizione petrarchesca, basandosi su rilievi di carattere grafico e paragrafematico compiuti sulle carte vaticane, per tentare di cogliere qualche elemento nuovo nel «sistema d’equilibrio dinamico» messo in pagina dall’autore dei Rerum vulgarium fragmenta; di seguito si tratterà brevemente delle prassi di conservazione e archiviazione libraria da lui adottate e del peso che hanno avuto nella trasmissione delle sue carte autografe. Nella seconda parte ci si soffermerà su alcuni episodi della storia della tradizione segnati dall’attiva presenza degli abbozzi petrarcheschi: la copia nel cod. Casanatense 924 da parte di Bartolomeo Sanvito; l’edizione muratoriana del 1711, basata su quella seicentesca di Federico Ubaldini; l’uscita dell’edizione critica del Canzoniere del 1896, per le cure di Giovanni Mestica.

Giovanni Boccaccio: quale volontà d’archivio?
Irene Iocca & Enrico Moretti
Nel testamento redatto il 28 agosto 1374 Boccaccio stabiliva che i suoi libri fossero affidati al frate agostiniano Martino da Signa, alla morte del quale la collezione doveva essere destinata sine aliqua diminutione al convento di Santo Spirito di Firenze, inventariata e collocata in appositi armadi. Da questa disposizione emerge il desiderio di salvaguardare la propria biblioteca dalle mire dei creditori e dagli inevitabili fenomeni di dispersione. Oltre alla conservazione, però, il testamento prescriveva che i codici fossero concessi liberamente per la lettura e la copia a chiunque lo desiderasse: non si trattava quindi di una semplice eredità materiale, ma di un lascito culturale destinato alla posterità. In che termini tale determinazione a conservare, tramandare e rendere fruibili i propri libri può essere intesa come una forma di volontà d’archivio? Per tentare di rispondere a questo interrogativo sarà necessario esaminare sia gli autografi del Certaldese sia le tradizioni manoscritte delle sue opere al fine di vagliare le possibili manifestazioni di una volontà autoriale connessa alla rappresentazione di sé che permettano di comprendere quale valore sia lecito attribuire alla donazione registrata nelle sue ultime volontà.
Chi volesse individuare tra le carte di Boccaccio indizi espliciti di un progetto volto alla costruzione di un’immagine di sé da consegnare alle generazioni future si troverebbe di fronte a un panorama desolato e dai contorni sfumati, costituito da tracce esili e incerte, tanto più indefinite se paragonate a quelle lasciate da Petrarca – inevitabile pietra di paragone di questo discorso –, costantemente impegnato a collocare sé stesso e il proprio operato nello spazio e nel tempo.
Nel vaglio delle testimonianze è necessario confrontarsi con due distinti ordini di problemi, connessi al tema della autorappresentazione. Il primo riguarda la frequenza e il modo in cui il Boccaccio trascrittore delle proprie opere rivendica a sé la paternità di un testo: si pensi anzitutto al noto enigma dello Zibaldone Laurenziano (codice probabilmente compreso nella donazione fatta a Santo Spirito), in cui come si sa il nome dell’autore è sistematicamente eraso (un dato notevole pur a fronte della difficoltà di stabilire la paternità dell’iniziativa). Tra gli autografi di opera propria conservati (più di una decina) il nome di Boccaccio compare quasi sempre nelle copie di opere erudite, ma non si riscontra nei testimoni delle redazioni del Trattatello in laude di Dante, né tantomeno nel codice Laurenziano del Teseida e nell’explicit del celebre autografo del Decameron. Un secondo corno del problema è rappresentato dall’indagine delle tradizioni manoscritte (prive o no di autografo), e nello specifico dall’analisi di come ciascuna di queste riceva e trasmetta l’indicazione di Boccaccio come autore dell’opera: per fare almeno due esempi significativi si può osservare come, legato al Decameron, il nome dell’autore non compaia a fianco del titolo dell’opera né nella tradizione più antica né nella tradizione più vicina allo scrittoio di Boccaccio; oppure, come in metà della tradizione dell’Amorosa visione manchi il verso dei sonetti acrostici al quale Boccaccio aveva affidato l’indicazione di sé come autore del testo e protagonista del viaggio allegorico.
Il secondo problema è legato all’attività di Boccaccio editore di opere proprie e altrui. Tale attività può ricondursi al desiderio di controllare la ricezione e fruizione delle proprie opere (è il caso, ad esempio, della funzione svolta dal sistema di maiuscole dell’Hamilton 90), ma anche, almeno in parte, alla volontà di creare un canone che coinvolgesse l’autore stesso: si pensi all’autografo della raccolta Chigiana che riunisce Dante, Cavalcanti e Petrarca e in cui Boccaccio inserisce, dichiarandone la paternità, il carme Ytalie iam certus honos; o ancora alla silloge pastorale, attestata da copie seriori, che raccoglieva la bucolica virgiliana, le egloghe petrarchesche e boccacciane, lo scambio tra Dante e Giovanni del Virgilio, nonché le due egloghe di Checco di Meletto Rossi. Le motivazioni che hanno spinto Boccaccio alla realizzazione di questi manufatti meritano di essere illuminate tenendo conto anche di due circostanze non prive di rilevanza: si tratta di codici allestiti nel corso degli ultimi anni di vita e, almeno per la raccolta pastorale, di un codice probabilmente compreso nel lascito a Martino da Signa. È legittimo intravedere dietro tali scelte autoriali un progetto di sistemazione della propria biblioteca e delle proprie opere in vista della loro cessione? In altri termini, vale la pena di chiedersi se quel lascito testamentario, sanzione in apparenza granitica della presenza di una volontà di archivio, nasconda il desiderio di consegnare un’immagine di sé o sia piuttosto espressione della volontà di garantire continuità ad un progetto culturale anche al di là del nome di Boccaccio, che pure in vita ne fu infaticabile promotore.

“Volontà” e “necessità” d’archivio: gli umanisti e l’organizzazione del sapere. Casi esemplari
Clementina marsico & andrea severi
Francesco Petrarca, come noto, inaugura un nuovo rapporto coi libri che influenza profondamente gli umanisti; lo studiolo o la «cella libraria» – secondo la definizione di Leon Battista Alberti – simbolo dell’Umanesimo, trasmesso da stampe e dipinti, ha come ipotesto ideale alcune memorabili Familiares ed Epystole. Petrarca, come nessun umanista dopo di lui, ha messo molto di sé stesso nella sua biblioteca, aggiungendo nei libri e nelle carte che la formavano anche annotazioni relative alle sue opere, affinché i lettori futuri potessero seguire l’evoluzione del suo io attraverso quello che, in un’accezione ampia, potremmo considerare il suo ‘archivio’. Questa fiducia/consapevolezza circa la possibilità che il proprio archivio possa tramandare alla posterità un’immagine di sé emerge solo raramente negli umanisti delle generazioni immediatamente successive a Petrarca. È piuttosto la necessità di ordinare una crescente mole di conoscenze sulle letterature antiche, greca e latina, che spinse gli umanisti a organizzare e schedare le proprie letture, sia per esigenze pratiche ed economiche (l’impossibilità di avere costantemente a disposizione ricche raccolte librarie), sia per pianificare i propri scritti, spesso di carattere lessicografico ed enciclopedico, volti a sistematizzare ampie aree del sapere. Le raccolte di questi materiali (miscellanee, zibaldoni, ‘archivi’ in senso moderno), fortunosamente arrivate fino a noi, ci consentono di avanzare alcune ipotesi sulle modalità di lavoro e di studio degli umanisti, la cui urgenza era quella di ripristinare e trasmettere il più possibile dell’humanitas antica – data l’accresciuta consapevolezza, rispetto a quella che aveva Petrarca, di quanto era andato perduto di essa. Tali raccolte si presentano come estremamente varie, perché soggette agli interessi del singolo studioso, alle differenti occasioni in cui vennero allestite, esibendo, di conseguenza, vari livelli di organizzazione formale. Pur nella loro disomogeneità, queste raccolte sono estremamente interessanti – per quanto non sempre di facile consultazione – perché consentono di ricostruire i profili culturali, i processi di elaborazione delle opere, i criteri sottostanti alla loro organizzazione. In parte affini alle tipologie documentali citate sono anche le recollectae o reportationes studentesche, che consentono di entrare nel laboratorio degli umanisti quali professori negli Studia, e che possono fornire, a seconda dei casi, informazioni sia sull’archivio del discente, sia su quello del docente, permettendo di riflettere sul concetto di ‘volontà multiple’.
Il contributo esaminerà alcuni casi famosi (da Lorenzo Valla ad Angelo Poliziano, passando per Giovanni Tortelli e Bartolomeo Fonzio), reperendo, laddove possibile, le tracce della fisionomia degli archivi di questi scrittori, e interrogandosi sui diversi gradi di consapevolezza con cui gli autori hanno considerato la funzione delle proprie carte. Ci si concentrerà, infine, su un inedito zibaldone autografo di Filippo Beroaldo, allestito negli ultimi anni del Quattrocento, tanto più interessante perché relativo a un momento storico in cui le biblioteche degli umanisti si andavano arricchendo di volumi a stampa.

Il “caso” Leonardo: un archivio in movimento
Roberto D’Urso

Archivi poetici di Iacopo Sannazaro e carmina estravaganti
Anita di Stefano
La mai interrotta osmosi tra studio degli auctores, esercizio filologico e attività versificatoria, caratteristica dell’esperienza letteraria di Iacopo Sannazaro, come d’altronde di molti protagonisti della stagione umanistica, è il punto di partenza per un contributo che si propone anzitutto di considerare entro un’ampia e polivalente accezione del concetto di “archivio” tutti i materiali radunati dal Napoletano a consolidamento della propria formazione poetica e in funzione della composizione dei carmina, nonché della loro sistemazione in raccolte appositamente progettate per la stampa: gli indici metrici approntati sui versi di Orazio, Ovidio, Stazio, i testi classici postillati (ad esempio di Marziale), i volumi e fascicoli di poesia tardoantica allestiti a ridosso delle scoperte di codici in Francia, gli stessi autografi delle opere latine, fitti di prove redazionali, rappresentano infatti, a mio parere, le componenti di uno stesso grande archivio di poesia, nella misura in cui risultano depositari, su iniziativa dell’autore stesso, di tasselli diversi di una sola e univoca vicenda.
Un focus su alcuni aspetti legati alla tradizione delle elegie e degli epigrammi, guardando alla struttura e alla funzione, diverse, dei due principali testimoni autografi, il Vaticano latino 3361 e il Viennese 9477, consentirà di valutare in concreto l’idea di una volontà d’archivio da parte del poeta.
Il manoscritto vaticano (= V) consegna, in più stesure, pressocché tutti i testi pubblicati nell’Aldina, postuma, del 1535, in parte ancora oggetto di interventi correttori, in parte già caratterizzati dalla facies di copie in pulito, organizzate secondo una studiata mise en page; alcuni componimenti in più rispetto alla stampa e qualche ‘assenza’, nonché un assetto testuale talvolta discrepante da quello dell’edizione lasciano verosimilmente individuare nell’autografo il penultimo anello di una catena redazionale chiusa da un successivo testimone, approdato in tipografia. Attraverso il vaglio della compagine e del contenuto del codice ho già avuto modo di riconoscere una consapevole volontà, in Sannazaro, di raccolta e conservazione di materiali poetici, di allestimento cioè di un volume, corredato di specifici paratesti, dalla chiara funzione di archivio e al tempo stesso di laboratorio artistico: tracce frequenti di calcoli relativi al numero di versi dei carmina, indicazioni di una loro disposizione e successione all’interno delle carte, indici delle elegie e degli epigrammi, con riferimento numerico al foglio in cui essi sono dislocati nel manoscritto, fitto lavorio di varianti negli spazi marginali e interlineari sono infatti classificabili come elementi significativi di una bozza progettualmente editoriale, ma anche di un’operazione documentaria di scelte accuratamente studiate dall’autore stesso; una raccolta di prove poetiche, spesso superate dall’infaticabile esercizio versificatorio, che tuttavia Sannazaro sembra riordinare in funzione di consultazione, ma anche di recupero di versi e iuncturae, da rielaborare e riversare in nuove stesure. In questa prospettiva, gli indici preposti alle due sezioni (elegiaca ed epigrammatica) attestano una prima fase progettuale dei libri carminum, sia pure ancora lontana, in particolare per le elegie, dal postumo ordinamento definitivo. Diversa la situazione prospettata dal secondo autografo, il codice viennese (= W), uno degli zibaldoni sannazariani, depositario di numerosi testi di studio dell’umanista, che accoglie ai ff. 114-137 stesure, complete o parziali, di 18 elegie e 8 epigrammi non confluiti nell’Aldina. La compresenza di moduli scrittori ascrivibili a periodi diversi della vita di Sannazaro, l’assenza, qui, di qualsiasi traccia di organizzazione/ordinamento dei materiali, la successione talvolta errata delle carte, la stessa facies strutturale dell’intero codice, imputabile a un’operazione esterna, non consentono di assegnare a W il ruolo di miscellaneo d’autore: esso ha anche ovviamente la funzione di archivio, ma assolve piuttosto il compito di una conservazione neutra dei materiali. Tuttavia, il fascicolo di poesia conservato dal codice di Vienna, nel tramandare un certo numero di testi epigrammatici estravaganti, per i quali non ci sono ragioni per pensare a una consapevole eliminazione da parte del Sannazaro, induce a chiedersi se una collocazione (e quale) essi avrebbero trovato nel disegno ecdotico immaginato dall’umanista e interrotto bruscamente dalla morte, e se sia possibile individuare una relazione tra il progetto autoriale rappresentato dall’archivio vaticano e la fase magmatica di cui sono specchio i fogli consegnati da W; la lettura degli epigrammi viennesi, in controluce con l’assetto ‘editoriale’ di V, consente ora di avanzare alcune considerazioni sul destino ultimo di componimenti mai approdati alla stampa ma non irrilevanti nell’ambito della scrittura sannazariana.

«In un quadernuccio nelle mie scatole»: spigolando tra le Carte Machiavelli
Daniele conti
Allo stato attuale delle ricerche della biblioteca privata di Machiavelli sono stati identificati appena due esemplari. Né, a quanto si sa, della raccolta libraria del Segretario fiorentino fu redatto un inventario. Le carte del suo archivio non godettero di maggiore attenzione. Quanto di questo patrimonio letterario e documentario è sfuggito alla dispersione è ora conservato quasi interamente presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze: la sezione più consistente si trova nel fondo Autografi Palatini (Carte Machiavelli), cui si aggiunge un nutrito gruppo di lettere responsive distribuite tra Ginori Conti 23, 28 e 29 e la cartella Nuove Accessioni 1004. Nell’archivio confluì una messe di scritti di varia tipologia, la maggior parte dei quali di carattere documentario e risalente al periodo ante res perditas. Scarse le testimonianze autografe di natura letteraria. È su questo ridotto manipolo di testi, oltre che su quelli relativi al carteggio privato, che fino ad ora si è prevalentemente concentrata la critica. È un’attenzione parziale che pare comprensibile se si guarda alle Carte Machiavelli dal punto di vista dell’editore di singole opere e dell’epistolario (diplomatico e privato), generalmente poco interessato alla congerie di carte contenenti appunti di Cancelleria, abbozzi e regesti di corrispondenza diplomatica, schedature amministrative, spesso trasmesse in forma frammentaria, che Machiavelli raccolse durante gli anni del segretariato e che spesso risultano di utilità limitata per stabilire rapporti dialettici tra archivio d’autore e opere politiche e letterarie. Del resto un generale accordo tra gli studiosi assegna a Machiavelli un atteggiamento di scarsa cura nei confronti delle proprie carte (autografe e non), e almeno in apparenza ben lontana da una definita volontà d’archivio.
Se tutto ciò contribuisce a spiegare la scarsa attenzione da parte degli studi alla considerazione delle Carte Machiavelli nella loro globalità, meno giustificabile è l’assenza di uno scavo sistematico affrontato con gli strumenti della paleografia e della codicologia, che soli potranno riuscire a collegare quanto una serie di riordinamenti successivi ha arbitrariamente diviso. La mancanza di adeguati mezzi di corredo è uno dei fattori che più osta a una valutazione non episodica dell’archivio machiavelliano. Dal punto di vista della catalogazione, si è ancora fermi al manoscritto Inventario topografico degli Autografi Machiavelli (presso la Sala Manoscritti e Rari della BNCF), e all’unico regesto completo delle Carte Machiavelli, organizzato secondo un criterio cronologico, che fornì Oreste Tommasini nel 1911.
Ma le indagini sull’archivio di Machiavelli devono tenere in considerazione sia l’osmosi tra scrivania dell’ufficio e scrittoio privato, proprio perché la maggior parte delle carte attualmente conservate risalgono al periodo del cancellierato, sia la trasmissione dell’archivio stesso successiva alla sua morte. Il primo punto obbliga a riflettere sul doppio ruolo di Machiavelli, quello del Segretario della seconda Cancelleria e quello del privato cittadino che insieme è politico, storico e letterato, sul modo in cui esso abbia agito sulla tipologia delle sue carte d’archivio, e infine sulla permeabilità dei confini tra scrittura pubblica e scrittura privata. Il secondo punto riguarda chi intenda considerare l’archivio machiavelliano nella sua interezza e muoversi lungo il duplice binario dello studio degli originali conservati e della tradizione di quelli perduti. In questo caso assume rilevanza decisiva il cosiddetto Apografo Ricci, manoscritto allestito da Giuliano de’ Ricci (1543-1606) – nipote di Machiavelli nonché erede e primo ordinatore delle sue carte – e destinato a raccogliere il materiale machiavelliano fino ad allora inedito. L’Apografo rappresenta in qualche modo un’estensione dell’archivio conservato di Machiavelli e un osservatorio privilegiato per gettarvi una luce riflessa. Il lavoro di riordinamento dell’archivio del nonno procedette contestualmente alla confezione del celeberrimo manoscritto. Le trascrizioni di Ricci improntate a fotografica fedeltà all’antigrafo in assenza dell’originale si sostituiscono ad esso con un buon grado di affidabilità, consentendo di recuperarne per via indiretta la fisionomia codicologica e persino di attingere a un discreto numero di ‘meta-postille’ machiavelliane. L’esame del codice, tuttavia, si è focalizzato in prevalenza su singoli scritti, limitandosi alla valutazione della sola qualità testuale. Questo approccio ha precluso una considerazione del manoscritto nella sua unità e quindi una ricognizione codicologica e contenutistica complessiva. Ciò non ha solo occultato l’acribia filologica dell’impegno di Ricci quale archivista-editore: ha anche obliterato la storia del processo di valorizzazione a posteriori di materiali presenti sì nell’archivio di Machiavelli, ma relegati in quaderni di lavoro (‘quadernucci’) che l’autore considerava meri depositi di informazioni e che solo grazie alle edizioni ‘semidiplomatiche’ di Giuliano hanno guadagnato uno statuto letterario. Attraverso selezionati affondi critici, seguire i due filoni di indagine e tenerli insieme è quanto si prefigge il presente intervento.

Alcune ipotesi sull’archivio di Pietro Bembo: le modalità di conservazione della sua corrispondenza
Francesco Amendola
Il presente contributo intende partire dall’esame delle fonti documentarie e di alcuni aspetti materiali, paleografici e codicologici (annotazioni, postille e tracce di piegatura delle carte), riscontrabili nei manoscritti compositi che tramandano le lettere di Pietro Bembo, per individuare una serie di pratiche che il nostro autore adottava con una certa sistematicità nella conservazione della propria corrispondenza. Tali pratiche lascerebbero ipotizzare l’esistenza di un vero e proprio archivio, che Bembo curava grazie all’ausilio dei suoi segretari e maestri di casa. La seconda parte del contributo proverà a fare luce sull’esistenza o meno di una “volontà d’archivio” nella conservazione della corrispondenza dell’autore. A tale scopo sarà adottata una prospettiva olistica, che tenga conto anche della storia e della formazione della biblioteca di Bembo, alla quale l’archivio deve essere almeno idealmente affiancato e sulla quale Massimo Danzi ha scritto pagine tutt’ora imprescindibili. È possibile rintracciare infatti varie finalità nell’archiviazione delle carte: da quelle puramente pratiche e documentarie, alla volontà di trasmettere ai posteri una precisa immagine di sé, che dovrà essere posta in rapporto dialettico con quella che l’autore intendeva trasmettere con l’epistolario, inteso come opera letteraria, destinata alla pubblicazione a stampa. Infine sarà indagata la storia della dispersione di tale archivio, che seguì la medesima sorte delle collezioni antiquarie e librarie di Bembo, che vennero vendute dagli eredi. Si descriverà in particolare il passaggio – avvenuto probabilmente all’insaputa dell’autore dopo la sua morte – di queste lettere, costituite da fogli sciolti e conservate singolarmente, in manoscritti compositi che sono poi confluiti, attraverso una serie di passaggi intermedi non sempre ricostruibili con chiarezza, nelle attuali collezioni della Biblioteca Apostolica Vaticana e della Biblioteca Ambrosiana di Milano.

Le carte di Giovan Giorgio Trissino tra archivio d’autore e memorie di famiglia
Franco Tomasi
Quanto ci rimane dei materiali autografi, dell’epistolario come anche della biblioteca di Giovan Giorgio Trissino non è che una parte, molto lacunosa e parziale, di un patrimonio che doveva essere assai più ingente e corposo. Se non è facile scorgere una precisa e determinata “volontà d’archivio” nelle carte superstiti del letterato vicentino, almeno non secondo un preciso disegno già pensato per una sorta di museificazione del proprio operato, appare però evidente una intenzione di conservazione sistematica delle proprie carte, che risale, si potrebbe dire, già al modus operandi che Trissino adotta per la composizione dei suoi testi, come anche delle sue carte personali, relative tanto al dialogo intellettuale con sodali, quanto alle vicende private e più strettamente collegate all’amministrazione dei beni di famiglia. L’intervento si propone allora di ricostruire, sulla base di materiali superstiti, l’archivio trissiniano, analizzando i frammenti dell’epistolario, uno zibaldone autografo conservato alla biblioteca braidense di Milano, e altri documenti di carattere più amministrativo.
Un gruppo significativo di documenti del letterato vicentino ci consente inoltre di osservare le modalità di conservazione e di archiviazione che la famiglia, nel corso dei secoli, ha operato. Verso la metà del Settecento gli eredi di Trissino, esponenti di una aristocrazia di provincia orgogliosamente intenzionata a celebrare il proprio aureo passato, affida a un gruppo di eruditi locali un lavoro di riorganizzazione sistematica di tutte le carte in loro possesso. L’esito di tale lavoro è ben ricostruibile sulla base di cinque ampi faldoni di manoscritti, oggi conservati in parte alla Biblioteca Braidense di Milano, in parte nel fondo Rothschild della Bibliothèque nationale de France, tutti corredati da materiali paratestuali che illustrano il lavoro compiuto dagli allestitori. Proprio sulla base di questi documenti, la cui storia verrà sinteticamente ripercorsa nell’intervento, si venne costruendo, nella seconda metà dell’Ottocento, la monografia di Bernardo Morsolin, lo studio che ancora oggi costituisce un punto essenziale di riferimento per gli studiosi.

Ariosto: le verità degli scartafacci
Ida Campeggiani
L’Ariosto che emerge dalle carte non è quello che si conosce tramite l’opera a stampa. Mi riferisco ad aspetti che riguardano la biografia, la lingua e la poetica, di cui solo i manoscritti sono testimonianza, tanto più alla luce della loro diversa e spesso fortunosa modalità di conservazione. Messi da parte, recuperati e copiati (o fatti copiare: da famigliari e non solo), oppure accantonati e talvolta – forse – persino occultati, i manoscritti possono dire molto sulle pratiche di scrittura (com’è ovvio) e insieme sull’atteggiamento di Ariosto rispetto alla propria opera (e rispetto al genere di volta in volta praticato: poema, satire, teatro, rime).
In questo senso lo studio dei fondi ariosteschi può dischiudere un’immagine semiprivata di messer Ludovico un po’ diversa rispetto a quella sancita dalla prestigiosa tradizione critica che fa capo a Croce, Contini e Segre. Il titolo vagamente “giudiziario” di questo intervento allude infatti all’opposizione latente tra le carte di un lavoro ancora instabile (in questo senso uso il celeberrimo termine scartafacci) e il paradigma interpretativo dell’armonia messo a punto da Croce e avvalorato poi da Contini nella sua recensione all’edizione Debenedetti dei Frammenti autografi (ben più nota dell’edizione stessa); e, in generale, all’opposizione tra le verità parziali e imperfette testimoniate da tali carte e la prospettiva teleologica che ha ispirato studi e edizioni fondamentali (Segre ha stabilito il testo di Satire e Cinque canti sulla base di un’idea astratta di lingua vicina a quella del Furioso del 1532 più che su criteri storico-paleografici – mi limito qui a rammentare che, pur essendo il massimo specialista del cammino linguistico di Ariosto, non si è mai occupato dei Frammenti autografi; e come lui, più tardi, altri studiosi della lingua ariostesca).
Se guardiamo dunque non alle stampe ma a ciò che non è arrivato alla stampa Ariosto vivente, e a ciò che in tipografia è arrivato ma per la massima parte è andato perduto (e che forse proprio la stampa ha contribuito a distruggere), osserviamo un panorama in parte ancora da descrivere. Alla sicura conquista dell’incanto e alla sanzione data all’opera dall’approdo a stampa si contrappongono vari casi di testi non-finiti nel senso di rifiutati, accantonati o conservati di nascosto, “nel cassetto”. Nel quadro di un’opera in divenire, depositata qua e là in un “archivio” virtuale (custodito, si fa per dire, in seno alla cerchia famigliare), la ripresa in mano dei fogli e la ricerca della forma pare piuttosto una sorta di risarcimento nevrotico: l’obiettivo di un Ariosto meno demiurgo, meno strapotente, ma anzi implicato in una materia che, come succede ai grandi della modernità, diviene un surrogato esistenziale, «forma di vita di chi veramente non vive». A maggior ragione di un’esistenza vissuta all’insegna del pro bono malum, oppressa dal servizio cortigiano, dalle mansioni di infelice governatore quando non addirittura di umile cavallaro.
L’intervento si articola in due parti: la prima è dedicata alla situazione filologica delle varie opere ariostesche, che non compongono un vero archivio ma forse rivelano alcune interessanti costanti relative alla “conservazione” dei testi: ad esempio la presenza di originali in movimento e – si può ipotizzare – la tendenza a lavorare su apografi (per lo più andati perduti). Si illustrerà anche una vicenda che suggerisce la lunga permanenza sullo scrittoio delle cosiddette “brutte copie” autografe e forse l’intento di “aggiornarle” e conservarle. La seconda parte è dedicata alla presenza di eventuali “meta-postille”, alle testimonianze epistolari e alle notizie (procurate anzitutto dall’erede universale, il figlio Virginio) che permettono di integrare – in via almeno ipotetica – le nostre conoscenze sul potenziale ordinamento delle carte letterarie ariostesche.

Gli archivi del Castiglione
Roberto Vetrugno
Gli archivi del Castiglione sono archivi possibili: assenza quasi totale di tracce e nessuna volontà di ordinamento da parte dell’autore, una storia “dispersiva” di testi e testimoni fuori controllo.
Dai manoscritti del Cortegiano non emerge alcuna pianficazione, nessuna prova che possa far ipotizzare una volontà d’autore di tramandare la propria opera. L’officina del Libro giunge a noi per vie traverse, per le cure di letterati ed editori che hanno valorizzato un patrimonio documentale di cui la famiglia Castiglioni si liberò quasi del tutto pochi decenni dopo la morte dell’autore. Le Rime e il Tirsi ebbero una gestazione pienamente cortigiana, nel senso di occasionale, di diffusione a corte tra gli amici con cui Baldassarre si divertiva a comporre (si pensi al sodalizio poetico con Cesare Gonzaga). Le tre “lettere” pubbliche (Lettera al Frisia in difesa delle donne, Lettera a Leone X, la Risposta al Valdés) sono anch’esse giunte prive di qualsiasi riconoscibile volontà d’archivio.
Esili prove dell’attenzione dell’autore nei confronti delle sue carte affiorano nel carteggio: tra le missive possiamo riconoscere l’intenzione di occuparsi prevalentemente della sua corrispondenza mentre accenna alle sorti di copie del suo Dialogo in pochissime occasioni. Quali furono le ragioni di questa volontà d’archivio epistolare e non letterario, di un possibile disinteresse verso la propria produzione letteraria? Il Castiglione non ebbe forse modo né tempo di ordinarla a causa degli eventi che lo travolsero negli ultimi anni trascorsi in Spagna? Le vicissitudini e le responsabilità del diplomatico non lasciarono spazio alle intenzioni dello scrittore, l’urgenza di una difesa di sé stesso e del papato, dopo il sacco di Roma, prevalse.
Non resta quindi che sondare ciò che accadde dopo il 1529: le incursioni nelle carte del conte mantovano di letterati e curatori che nei secoli raccolsero e ordinarono le sue opere, da Bernardino Marliani nella seconda metà del Cinquecento fino al secolo scorso con Guido la Rocca.

Il governatore e lo storiografo. Affioramenti di una volontà di autore nelle carte di Francesco Guicciardini
Lorenzo Battistini & Paola Moreno
L’Archivio Guicciardini, sito a Firenze nella casa che da sempre appartiene alla famiglia, è un raro esempio di collezione quasi integrale delle carte di un autore. Vi si trovano infatti le carte di Francesco Guicciardini, tutte contenute in 27 filze debitamente rilegate e conservate in un armadio.
Purtroppo, però, alla ubicazione in un unico luogo non corrisponde un’organizzazione coerente, né antica. Diverse mani, nel corso dei secoli, hanno sconvolto quello che doveva essere l’assetto originario delle carte guicciardiniane, rendendo oggi poco leggibile la volontà organizzatrice dell’autore.
Alcuni affioramenti di questa volontà possono tuttavia ancora essere identificati e descritti. Dalle modalità di conservazione della ricca corrispondenza si possono trarre informazioni sul modo in cui Guicciardini utilizzò le lettere come fonti per l’elaborazione del suo pensiero politico e per la scrittura della storia. E l’analisi dell’ordinamento dei materiali preparatori alla redazione del suo capolavoro, la Storia d’Italia, può darci indicazioni preziose sul modo in cui egli concepì il suo ‘laboratorio’ storico. Il nostro intervento mira a proporre alcune piste ermeneutiche che tengano conto della vicenda biografica di Francesco Guicciardini, pubblicamente impegnato nell’azione di governatore e privatamente, anzi segretamente, nell’attività di scrittura. L’analisi del suo archivio porterà a scoprire un po’ più di quanto si sia fatto fino ad ora il velo di questo Guicciardini segreto.

L’ambiguità dell’archivio: il caso di Pietro Aretino
Marco Faini
Il mio intervento intende prendere in esame l’ambiguo e in parte contradditorio caso della volontà d’archivio aretiniana. Da un lato, infatti, Aretino mette in opera abbastanza precocemente una radicale e complessa (ri)organizzazione – con procedimenti di esclusione, revisione e riscrittura – del proprio archivio epistolare in vista della pubblicazione dei libri di lettere sue e a lui dirette. Dall’altro, soprattutto in rapporto alla propria produzione poetica, Aretino sembra voler scientemente negare ogni volontà d’archivio, giungendo fino a negare o mettere in dubbio l’idea stessa di autorialità (nel caso delle pasquinate) e, dunque, di volontà d’autore. La strategia aretiniana risulta dunque in una fitta e accorta presenza nel mercato della stampa alla quale si contrappone un apparente disinteresse per il destino delle proprie carte. I relativamente pochi autografi superstiti, soprattutto in rapporto a una produzione “miracolosamente” sovrabbondante, la mancanza di sillogi poetiche d’autore e di materiali preparatori (salvo labili tracce), sembra del resto singolarmente consonante con la poetica del “far presto e del suo”, la più volte affermata velocità e naturalezza della scrittura aretiniana. Nella prima parte dell’intervento prenderò dunque in esame le modalità della volontà d’archivio aretiniana, mentre nella secondo proverò a suggerire come essa s’intersechi con la sua peculiare poetica.

Giovanni Della Casa e il nipote Annibale Rucellai: ipotesi su un archivio
Claudia Berra
La maggior parte degli autografi e delle carte di Giovanni Della Casa è custodita presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV). I manoscritti Vat. Lat. 14825-14837 appartenevano all’archivio della famiglia Ricci Parracciani, custodito a Roma a palazzo Ricci e poi nel palazzo avito di Montepulciano; furono consultati nei secoli solo da pochissimi studiosi per realizzare studi ed edizioni. Il resto dell’archivio nel 1983, dopo la cessione del palazzo Ricci al Comune di Montepulciano, fu consegnato in deposito al Comune quindi restituito ai proprietari, che lo collocarono a Casole d’Elsa, sotto la tutela della Soprintendenza. Lì fu sporadicamente frequentato da studiosi soprattutto per studi di storia dell’arte, in particolare su Villa Medici e sulle committenze del cardinal Giovanni Ricci.
Di fatto, benché la scheda SIUSA fosse in linea dal 2005, si era persa, nel circuito degli studi storici e italianistici, la nozione della pertinenza di questo archivio alle famiglie Della Casa e Rucellai: non poté consultare questi materiali, perché allora non disponibili, Raffaella Zaccaria nel suo importante studio I Rucellai da Firenze a Roma (1992), l’unico esistente sul ramo romano della famiglia, che si fonda sull’archivio Rucellai di Firenze; né, più di recente, l’archivio è stato utilizzato per le voci Rucellai, Annibale e Rucellai, Orazio del Dizionario biografico degli Italiani (2017).
Nel 2018 l’Unità milanese (che ho coordinato) del PRIN 2015 “Repertori epistolari del Cinquecento” (PI Paolo Procaccioli) grazie alle ricerche di Michele Comelli ha individuato materiali di grande interesse, di Della Casa e della famiglia Rucellai (suoi cognati e nipoti), e ha iniziato a studiarli durante alcune visite successive. Ne è risultata una maggiore conoscenza dell’autore e una diversa ricostruzione della tradizione e dell’organizzazione delle sue carte, nella quale ha un ruolo determinante la figura di Annibale Rucellai, il nipote prediletto dell’Arcivescovo, che fu a sua volta un uomo di cultura, un diplomatico e politico curiale di rilievo.
A latere, sono stati segnalati documenti non dellacasiani, ma del più alto interesse per lo studio della storia politica e religiosa del Cinquecento.
Purtroppo, nel 2021 la villa dove era conservato l’archivio è stata messa in vendita, l’archivio stesso inscatolato e depositato presso una nota casa d’aste in attesa di un acquirente. Lo studio è proseguito, utilizzando le riproduzioni che si erano fatte per cortesia dei marchesi Ricci: se ne presenteranno i risultati, purtroppo per ora parziali, nell’auspicio che questo eccezionale patrimonio documentale possa tornare disponibile.

La volontà d’archivio nelle carte di Benedetto Varchi: un consuntivo
Dario Brancato
Negli ultimi anni si è assistito a un rifiorire di studi su Benedetto Varchi (1503-1565), grazie anche a studi pionieristici che ne hanno messo parzialmente in luce il pensiero e lo spessore culturale. Il suo valore intellettuale, liquidato forse troppo sbrigativamente come quello di un poligrafo privo di qualsiasi talento poetico, accademico o storico, può essere riconsiderato anche attraverso un esame d’insieme delle sue carte, fortuitamente conservatesi. Esse ci consentono di studiare il laboratorio di scrittura poetica e storica di Varchi e ne rivelano le strategie di composizione, rielaborazione e riordino delle sue opere. Il mio intervento, dunque, si propone di presentare due casi complementari, quello della produzione poetica in volgare e della Storia fiorentina attraverso l’esame dei materiali d’autore a noi pervenuti.

Volontà d’archivio imperfetta vs volontà d’autore negata nei quaderni storico-linguistici di Vincenzo Borghini
Davide Cappi
Vincenzio Borghini (1515-1580) è un esempio macroscopico di divaricazione tra indefessa attività scrittoria (in vari ambiti: religioso, storico, linguistico-letterario, artistico) e tenace renitenza alla pubblicazione a mezzo stampa. L’archivio (sempre in fieri) dei suoi manoscritti e postillati fu per lui non solo uno strumento del proprio lavoro, ma anche un viatico lasciato a chi fosse stato incaricato di gestire la sua eredità bibliografica. L’analisi comparata dei vari elenchi dei suoi libri (dopo Bertoli 1999 e Belloni 1999 e 2000, vedi Arcari 2011 http://dspace.unive.it/handle/10579/1087) è indispensabile per delimitare e descrivere la sua biblioteca, facilitando le sempre possibili (ed effettive) riscoperte di pezzi dispersi. Nei manoscritti, in particolare, si rileva una ricca tipologia di note di rinvio interne (chiave indispensabile per tentare di chiarire l’intricata cronologia relativa dei quaderni), spesso di carattere progettuale (anche postumo). Ricorrenti gli avvertimenti di Borghini, rivolti a sé stesso ma anche ai futuri lettori, circa la frammentarietà e provvisorietà delle sue riflessioni, da destinare con molta cautela a un’eventuale pubblicazione. Come esempio di ricerca nell’archivio di Borghini si approfondisce il caso delle note e degli appunti relativi al Trecentonovelle di Sacchetti (la cui scoperta e conservazione è grande merito di Borghini).

Contrastare la dispersione: Tasso e i suoi manoscritti dopo Sant’Anna
Emilio Russo
l destino delle carte di Torquato Tasso sembra rispecchiare, tra dispersione e vaste lacune, la biografia accidentata del poeta, divisa in due dalla reclusione nell’Ospedale di Sant’Anna (1579-1586). Mancano la gran parte degli autografi delle opere della prima stagione, e anche il dossier della lunga e complessa lavorazione della Liberata è andato in buona misura perduto; sono più numerose le testimonianze degli anni ’80 e ’90 della scrittura di Tasso, ma anche per questa stagione sembra dominante una dinamica confusa, per la quale gli autografi tassiani, anche quelli delle opere più importanti, sono smarriti o conservati in maniera parziale e fortunosa. A fronte di un quadro del genere appare difficile, anche per il modo in cui il Tasso spese i suoi ultimi anni, in movimento irrequieto tra diverse città, individuare una volontà d’archivio, un effettivo progetto di articolazione e conservazione delle proprie carte; e tuttavia è possibile cogliere, tra le pieghe di alcuni manoscritti, e in alcuni preziosi elenchi di libri e autografi, un tentativo di Tasso di arginare la disseminazione dei suoi manoscritti, e di dare una forma (per via di selezione) al magma dei suoi testi. Si tratta di materiali scarni e tuttavia eloquenti, che si tenterà di approfondire, anche attraverso una loro puntuale datazione e un inquadramento negli ultimi anni del poeta.

Galileo e i galileiani: un archivio polifonico
Sara Bonechi
Le vicissitudini dell’archivio di Galileo, tutt’uno con quello dei suoi discepoli, sono inscindibili dalle ricadute della sua condanna, tanto lui vivente quanto nei secoli a venire, e dai tentativi a lungo malriusciti di pubblicare l’edizione completa delle sue opere. Salvate da parenti e amici fidati durante la prigionia romana e l’esilio senese, le carte di Galileo rientrarono in suo possesso nel periodo del confino ad Arcetri e, fallito un piano editoriale concordato con gli Elzeviri a Leida, restarono in famiglia dopo la sua morte, per passare poi nelle mani di Vincenzo Viviani, il suo ultimo allievo, che si era assunto l’onere di conservarle e pubblicarle integralmente con l’aggiunta, a corredo, di una vita del maestro.
Col supporto e la protezione del granduca Ferdinando II e del fratello Leopoldo de’ Medici, promotori di lì a poco dell’accademia galileiana del Cimento, il Viviani recuperò manoscritti e corrispondenza sparsi da Galileo in tutta Europa. Non giudicò all’altezza dei contenuti il disegno di edizione delle opere di Galileo portato avanti a Bologna dall’editore Carlo Manolessi con la benedizione del principe Leopoldo e vi collaborò assai tiepidamente, riservando per sé la stragrande maggioranza dei materiali. Ma il persistere della proibizione che pesava sulle scritture copernicane, le continue incombenze di cui veniva gravato dalla magistratura dei Capitani di Parte Guelfa come ingegnere addetto al monitoraggio dei corsi d’acqua, l’avvicendamento ai vertici del granducato di Toscana con la nuova politica culturale di Cosimo III di forte impronta filoclericale, oltre a una naturale tendenza all’autocensura, portarono il Viviani a procrastinare il progetto lungo tutto l’arco della sua vita, sì che né l’edizione né la biografia (e neppure un lavoro analogo pensato per le opere di Evangelista Torricelli) videro mai la luce.
Se nel testamento si era preoccupato di destinare la propria biblioteca allo Spedale di Santa Maria Nuova, non facendo alcun cenno all’archivio che nascondeva in casa, il Viviani lo rese parte integrante del patrimonio lasciato al nipote Jacopo Panzanini, matematico anch’egli e suo erede universale. Gli interessi dell’abate Panzanini non coincidevano con quelli dello zio, e se si eccettua il matematico Guido Grandi che se ne servì per collaborare alla prima edizione fiorentina (mutila e incompleta anch’essa) delle opere di Galileo curata nel secondo decennio del Settecento dall’erudito Tommaso Buonaventuri, l’archivio galileiano non fu più oggetto di particolare attenzione, fino a perdere ogni tutela nel passaggio agli eredi successivi che neppure si resero conto del valore di quanto era stato loro legato.
Alla metà del Settecento, in seguito a una dispersione sciagurata e a un recupero che ha tutta l’aria di leggenda e fu invece realtà, le carte divennero proprietà del letterato e bibliofilo Giovan Battista Clemente Nelli, futuro cavaliere e senatore fiorentino, erede in seguito dell’intero patrimonio Viviani grazie a un fedecommesso disposto per testamento dall’ultimo discepolo di Galileo. In quegli anni in cui l’idea illuministica dell’utilità pubblica di scienze e lettere influenzava i comportamenti umani, in cui si aprivano musei a fini educativi e si lasciavano per testamento intere librerie ad uso della cittadinanza, il Nelli incrementò la propria raccolta, disponendo che alla sua morte i figli ed eredi, in caso di vendita, dessero diritto di prelazione ai sovrani di Toscana che avrebbero potuto acquistarli per le biblioteche della città.
Contro l’aggiramento di questo vincolo sarebbero state le stesse autorità statali a intervenire nei primi anni dell’Ottocento, quando Maria Luisa di Borbone, reggente del fugace Regno di Etruria, fece bloccare una vendita privata in violazione delle volontà del Nelli e ordinò il sequestro dell’archivio: un primo passo verso l’acquisizione da parte della Biblioteca Palatina che sarebbe stata formalizzata qualche anno dopo sotto Ferdinando III di Lorena. Per la prima volta le carte di Galileo e dei suoi discepoli erano divenute proprietà pubblica. Il primo nucleo di provenienza Nelli fu integrato e unificato ope legis con nutrite tracce documentarie che la tradizione galileiana aveva lasciato nel corso secoli in altri archivi e biblioteche locali: Firenze poteva così dedicare un monumento di carta a una delle sue glorie maggiori.
Unita l’Italia, in un clima in cui l’idea positivista di progresso e l’aspirazione al rigore del metodo scientifico in ogni ramo del sapere umano rendevano Galileo una figura quasi mitologica nel pantheon laico del neonato Stato, il confluire del fondo Palatino fra i manoscritti della Biblioteca Nazionale di Firenze agevolò la pubblicazione delle sue opere complete, ponendo rimedio a tutte le precedenti occasioni perse. Con l’edizione nazionale curata da Antonio Favaro e patrocinata dal re d’Italia, bandiera della moderna filologia e del positivismo storico che equiparava il documento al dato scientifico, non si pubblicarono solo i manoscritti raccolti nella collezione originaria, ma se ne reperirono infiniti altri, nelle biblioteche italiane e straniere come sul mercato antiquario. Fra quello che fece acquistare e quello che donò, anche Antonio Favaro contribuì ad accrescere il fondo di svariate decine di faldoni, frutto questa volta della ricerca scientifica e della tenace determinazione di uno studioso.
A partire da Galileo, quindi, discendenti, amici, allievi, istituzioni, amatori, professionisti, intellettuali, con motivazioni e spinte ideali via via diverse, hanno protetto queste carte dai tentativi deliberati di cancellarne il messaggio, o semplicemente dall’incuria, e hanno dato alla collezione galileiana la fisionomia attuale, che adesso è nostro compito preservare.

«Correzioni, miglioramenti e aggiunte». L’odissea editoriale delle opere di Vico
Raffaele Ruggiero
La pubblicazione delle opere di Vico – la Vita scritta da se medesimo, il Diritto universale e le varie edizioni della Scienza nuova – è stata accompagnata da una serie di vicissitudini editoriali che non solo hanno lasciato tracce evidenti nelle carte del filosofo (in gran parte presso la Biblioteca nazionale di Napoli) ma hanno determinato anche lo sviluppo del suo pensiero fino al maestoso cantiere delle quattro serie di «Correzioni, miglioramenti e aggiunte» alla Scienza nuova, segnando così il suo «destino di letterato». Ci proponiamo di seguire queste vicende tipografiche e di indagarne l’influenza sulla scrittura vichiana e sullo sviluppo del suo progetto intellettuale.

«Questo umano affetto e desiderio di viver dopo la morte». Appunti sulla ‘volontà’ d’archivio in Alessandro Tassoni
andrea Lazzarini
Alessandro Tassoni (1565-1635) fu legato alle sue carte da un rapporto complessivamente ambiguo. L’autore della Secchia rapita fu in vita postillatore scrupoloso (per non dire maniacale) di opere antiche e moderne, compilatore di strumenti utili al suo lavoro di erudito e storico, possessore di libri anche rari. La sua biblioteca romana raggiunse dimensioni senz’altro ragguardevoli.
Allontanatosi dall’Urbe durante gli ultimi anni di vita, Tassoni raggiunse prima Bologna al seguito del Cardinal Ludovisi e, poi, la nativa Modena, dove entrò al servizio degli Este. Egli di fatto ‘abbandonò’ a Roma la maggior parte dei propri volumi, dimostrandosi interessato soltanto alla sopravvivenza di poche opere manoscritte (in particolar modo il Ristretto degli Annali di Baronio al quale andava lavorando da una ventina d’anni).
L’intervento vorrebbe essere l’occasione per riflettere sul contraddittorio e barocco senso di vanitas che caratterizzò il rapporto di Tassoni col suo ‘archivio’. Vivente l’autore, questo dev’essere stato organizzato in modo funzionale alla raccolta di informazioni erudite: infatti, senza gli adeguati strumenti, la stesura di opere caratterizzate da una natura almeno parzialmente compilativa – quali le Considerazioni sopra le Rime del Petrarca (1609), i Pensieri (1612-) o gli stessi Annali – sarebbe stata senza dubbio impossibile.
Il discorso toccherà in particolar modo i ben nove testamenti conservati, e cercherà di interrogarsi sulla possibile relazione tra la dispersione delle carte e dei volumi tassoniani e il non sempre lineare rapporto dell’autore con la propria eredità terrena. Tassoni guardava alla morte in modo tormentoso, dimostrando un sinistro disprezzo per il destino riservato al proprio corpo. Gli stessi atti testamentari sono rivelatori di oscillazioni notevoli nella volontà dell’autore di organizzare il proprio lascito documentario. Per qualche tempo egli pensò finanche di finanziare coi propri beni la fondazione di un’Accademia modenese votata all’esercizio di lettere ed armi. Anche le poche testimonianze relative alla sopravvivenza della biblioteca romana dell’autore dopo la sua morte saranno prese in considerazione, così come le probabili ragioni che motivarono la decisione, purtroppo solo momentanea, di lasciare tutti i propri autografi in legato all’archivio della Comunità di Modena.

Gli “armari” di Metastasio
Valentina Gallo
Poco si sa dell’archivio di Metastasio, lasciato in eredità a Giuseppe e Marianna Martinez: alla morte degli eredi una parte del deposito documentario fu disperso, un’altra confluì nella biblioteca Imperiale di Vienna e un’altra ancora giunse in possesso di Giuseppe Asburgo Lorena palatino d’Ungheria, che nel 1823 la donò alla biblioteca reale di Budapest (Országos Széchényi Könyvtár). Attraverso lo studio delle carte, incrociando dati desunti da fonti indirette e dalla letteratura critica, la studiosa cercherà di ricostruire – con tratto leggero – la struttura originaria dell’archivio metastasiano e di definire il rapporto che Metastasio ebbe con i suoi scrigni poetici, interrogandosi sulle ragioni della conservazione e su quelle (più sfuggenti) della distruzione.

Jean-Jacques Rousseau: l’archivio e il Panthéon
Nathalie Ferrand
Jean-Jacques Rousseau offre un caso di studio esemplare per osservare le manifestazioni di una volontà d’archivio in uno scrittore dell’età moderna. L’autore ha infatti conservato una parte significativa dei suoi manoscritti, li ha riordinati, e si è premurato di garantirne la conservazione perenne affidandoli, per blocchi successivi, a diversi depositari. Questa pratica intenzionale spiega la distribuzione sparsa del suo archivio quale lo conosciamo oggi: accanto ai tre principali nuclei di conservazione delle sue carte (a Parigi e Neuchâtel sin dal 1794, poi a Ginevra a partire dalla seconda metà del XIX secolo) si assiste a una disseminazione delle carte di Rousseau su scala mondiale, fino in Asia, dove alcuni manoscritti sono confluiti alla biblioteca nazionale di Taiwan.
Ripercorrendo l’odissea dei manoscritti di Rousseau vivente l’autore e individuandone i momenti chiave presenteremo la singolare fisionomia del suo archivio (comprensivo anche della sua biblioteca) per meglio delineare l’intenso rapporto di questo scrittore con le proprie carte e l’affascinante relazione tra l’opera pubblicata e i testimoni della sua genesi.

Autobiografia e biografia. Funzioni e usi dell’archivio privato di Pietro Verri
Pierre Musitelli
Nel 1763, all’età di trentacinque anni, Pietro Verri archivia la prima fase della sua produzione letteraria in un faldone confezionato con cura. Questa raccolta eterogenea, che contiene un florilegio dei suoi scritti giovanili (teatro, poesia, romanzo, satira), coincide con un momento di svolta nella carriera intellettuale dell’autore che, tralasciando la vena galante e mondana, intende d’ora innanzi scrivere da filosofo e da economista.
Per tutta la vita, Verri conserva diligentemente le sue carte manoscritte, classificandole e dettagliandone il contenuto in note autografe apposte sulle cartelle. Aggiunge in calce ad alcuni fogli commenti di apprezzamento o di critica. “Sciocchezza”, osserva; “Povero Pietro”, annota altrove apostrofandosi; o ancora: “È troppo servile in ogni sua parte, non mi piace”. La pratica dell’archiviazione, volta a delineare un processo di maturazione intellettuale, possiede una dimensione autobiografica, rafforzata dalla presenza fra le carte inedite e postume di lettere e di testi introspettivi di giustificazione morale e politica. Verri si accinge a costruire un’immagine di sé per la famiglia, gli amici e la posterità — un’immagine alla quale manca tuttavia l’unità e la completezza che le avrebbe conferito la redazione di una vera e propria autobiografia.
Esamineremo l’uso che Pietro Verri fa dei suoi manoscritti, la funzione dei suoi commenti archivistici e lo status dell’opera inedita rispetto a quella pubblicata, prendendo anche come base di confronto altri archivi di scrittori a lui contemporanei, in particolare Cesare Beccaria. Ci interrogheremo anche sull’uso che gli studiosi e biografi di Pietro Verri hanno fatto dell’archivio privato dell’autore nel corso dell’Ottocento e del Novecento, tenendo presente l’ammonimento di Carlo Capra, che sottolineò nel 2002 il «pericolo» insito in queste carte: creare un «gioco di specchi» e di falsi sembianti del quale il lettore rischia di rimanere prigioniero.
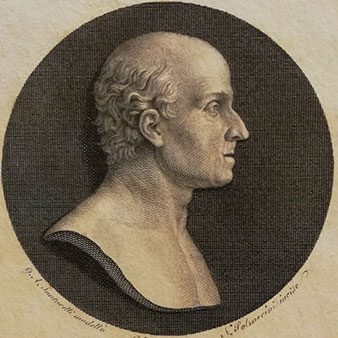
Dall’archivio alla vita: la «bibliotheca scelta per il cuore e per la mente» di Pelli Bencivenni
Laurence Macé
Giuseppe Pelli Bencivenni, noto personnagio del sistema culturale toscano della seconda metà del Settecento, è ben noto agli storici, che da decenni attingono come fonte documentaria al suo Diario (1748-1808), rimasto manoscritto. Il Diario è una delle poche tracce del ben più vasto archivio di Pelli Bencivenni, che è stato contemporaneamente o successivamente giudice, censore, giornalista e direttore degli Uffizi. La comunicazione intende tracciare la fisionomia complessiva del suo archivio, mettendo in luce gli aspetti che possono qualificarlo come “archivio d’autore” e analizzando le molteplici funzioni che esso svolge agli occhi del suo autore: dalla conservazione alla sperimentazione, dall’invenzione alla costruzione di sè.

Un «archivio autoritratto»: Vittorio Alfieri e i suoi manoscritti
Monica Zanardo
L’archivio letterario di Vittorio Alfieri si offre agli studiosi come un complesso documentario organico e compatto: al netto di una fisiologica (ma molto contenuta) dispersione e della dolorosa perdita di alcuni materiali – lasciati a Parigi quando l’autore fu costretto ad abbandonare la Francia – si tratta di un archivio che permette di seguire il percorso intellettuale di Alfieri, dalla fase della “conversione” letteraria fino alle opere mature.
Con le sue Ultime volontà Alfieri ha lasciato disposizioni dettagliate in merito alle sue carte e alla biblioteca personale, che legò alla propria compagna, la Contessa d’Albany. Se si rivela tutto sommato convenzionale l’attenzione che l’autore ha riservato alle opere da pubblicarsi postume, più significativa è la cura con cui Alfieri ha conservato i propri scartafacci e vari materiali sostanzialmente alieni da finalità editoriali: proprio questi documenti si rivelano preziosi per sondare l’uso strategico dell’archivio messo in atto da Alfieri e il dialogo strettissimo che esso intrattiene con il progetto autobiografico.
Tramite l’allestimento di miscellanei d’autore, la conservazione delle fasi compositive delle proprie opere (soprattutto delle Tragedie, ma non solo), e l’apposizione di metapostille, Alfieri modella un archivio pensato esplicitamente per i posteri, presso i quali esso doveva farsi garante di autenticità di quanto narrato nella Vita.
In primo luogo, Alfieri esibisce (con una singolare strategia di misunderstatement) alcuni materiali della fase della formazione: sapendo di non poterli occultare, li offre al lettore / fruitore dell’archivio con ostentata autoironia, facendone il punto di partenza del suo lungo e complesso itinerario verso la gloria letteraria. Carte di guardia facenti ufficio di frontespizio e metapostille sapientemente disseminate concorrono a chiarire lo statuto di questi documenti.
In secondo luogo, l’autore conserva una selezione dei materiali genetici delle proprie opere e, in particolare, delle Tragedie: i lettori più fedeli vi troveranno la conferma del suo metodo compositivo, da lui accuratamente descritto tanto nella Vita quanto nel Parere sulle Tragedie. Ereditando una tradizione filologica di lunga data, Alfieri si mostra cosciente del potenziale pedagogico dei manoscritti d’autore, da lui stesso esperito nel corso della sua formazione, e si offre egli stesso come modello.
Inoltre, Alfieri utilizza il proprio archivio per saldare la propria immagine autoriale alla propria opera letteraria: le note di tipo autobiografico e diaristico, disseminate in tutto il suo archivio ma presenti con particolare insistenza nei materiali preparatori delle Rime, concorrono a far trasparire l’uomo dietro l’autore, la quotidianità dietro la sua trasfigurazione letteraria. In molti casi, però, si tratta di note che sembrano presupporre un lettore esterno, un destinatario, e sulla cui spontaneità è lecito sollevare qualche sospetto.
Nel complesso l’archivio alfieriano, lungi dall’essere il frutto di una stratificazione aleatoria dei documenti, si rivela un insieme sapientemente costruito, al quale Alfieri ricorre strategicamente per offrire un ritratto di sé attentamente studiato. Consapevole del credito di autenticità che tendenzialmente si presta ai materiali autografi, l’autore li usa come prove (nel senso giuridico del termine) a garanzia del proprio autoritratto: nel farlo, però, piega il “vero geometrico” al “vero ideale”.
Una tale consapevole “intenzione d’archivio” (che va oltre la mera “volontà”) fa sistema con un elemento centrale nella poetica dell’autore, e rivendicato con particolare fermezza nel trattato Del Principe e delle lettere: in una concezione etica e impegnata della letteratura, il giudizio sull’Opera non può e non deve prescindere dal giudizio sull’Autore. Alla luce di questa presa di posizione l’archivio letterario, in quanto luogo di maggiore prossimità tra l’autore e la sua opera, diventa uno strumento fondamentale per Alfieri, che ne fa un vero e proprio “autoritratto”, volto ad orientare, attraverso le proprie carte, la ricezione insieme della propria persona e della propria opera.

«Memore della mia promessa, ho raunato parecchie altre mie operette per farne dono alla detta Biblioteca…»: il “caso” Monti fra censura, manipolazione e dispersione
Luca Frassineti
Pregiatissimo signor Abate. – Il cav. Zanoli mi aveva già data speranza della venuta vostra in Milano. La vostra dei 24 decembre, ricevuta solamente ieri, me la conferma, e ne provo molto piacere, perché nella mia lontananza dalla patria niuna cosa mi è sì cara quanto il consolarmi della presenza di qualche amico concittadino, consolazione che di rado mi avviene. Siate adunque sicuro che sarò lieto assai di conoscervi e ringraziarvi dell’onore che fate alle cose mie in cotesta pubblica Biblioteca, secondo ciò che il Zanoli mi dice. Memore della mia promessa, ho raunato parecchie altre mie operette per farne dono alla detta Biblioteca. E avrete principalmente la nuova edizione, che è sul finire, non solo di quanto trovasi in quelle di Parma, Pisa, Siena, Napoli, Verona, ma di tutte ancora le poesie che mi è accaduto di scrivere in Milano dopo la venuta del Tedesco. Ma da questa edizione per inevitabile mia sciagura sono sbandite tutte le poesie che odorano di libertà, che è quanto dire tutto che ho scritto dal 98 del secolo andato fino al 14 del presente, che appunto è la parte migliore delle mie fatiche. Ho molti inviti da Londra a farne colà una completa edizione. Ma i regolamenti mel vietano della vigente Censura, e il violarli porterebbe la mia ruina. Intanto la pirateria degli stampatori fuori di Stato mi assassina. Nella sola Firenze sonosi pubblicate cinque edizioni della mia Iliade, oltre quelle di Brescia, di Milano e di Napoli, e tutte le esterne senza verun mio profitto. Altrettanto si è fatto delle tragedie per tutta l’Italia. Della Bassvilliana non parlo, di cui tutto dì a mio pregiudizio si moltiplicano le edizioni, le quali già s’appressano al centinaio, e a me povero autore non ne viene il guadagno neppur di qualche copia in regalo. Tale in Italia è la misera condizione de’ letterati, per non essersi mai tra’ Governi italiani convenuta una reciproca garanzia della proprietà degli scritti a pro degli autori.
cfr. Epistolario di Vincenzo Monti. Raccolto, ordinato e annotato da Alfonso Bertoldi, vol. VI, Firenze, Le Monnier, 1931, pp. 153-54,n. 2789, da cui si cita.
Così, il 9 gennaio 1826, a poco meno di due anni e mezzo dalla sua scomparsa, Vincenzo Monti scriveva al giovane Primo aggiunto della Biblioteca Civica di Ferrara, l’abate Giuseppe Antonelli (1803-1884), in continuità con il dialogo a distanza avviato almeno a partire dall’estate del 1824 con il Conservatore-capo, il canonico comacchiese Felice Prospero Cavalieri Ducati (1768-1833), redattore dei primi dodici volumi (dal 1802 al 1815) del catalogo dei libri della biblioteca estense. In quei frangenti, infatti, Cavalieri si era premurato di far collocare presso i locali dell’istituzione da lui retta un ritratto del poeta, trasposizione litografica, per cura del libraio-tipografo Filippo Benetti, di un busto attribuito allo scultore neoclassico Abbondio Sangiorgio, poi donato (nel 1882) da Ercole Monti e oggi esposto nella “Sala Caretti” della stessa Biblioteca Ariostea. Contestualmente, il 27 agosto 1824 una seconda copia del ‘simulacro’ di Monti aveva trovato sistemazione «di fronte a quello di Ludovico Ariosto» nel Teatro dell’Accademia filodrammatica – già Teatro Bonacossi – di Ferrara (cfr. Epistolario di Vincenzo Monti, cit., p. 42,n. 2654, da cui si cita), fissando simbolicamente il passaggio di testimone fra la gloria del narratore cinquecentesco e quella dello scrittore contemporaneo, in proiezione revanscistica sia cittadina sia nazionale.
La nuova stima del lascito montiano alla Biblioteca di Ferrara in senso ‘modellizzante’ rispetto a una precisa ‘volontà d’archivio/volontà d’autore’– tanto più significativa perché realizzata in limine mortis (i.e. 13 ottobre 1828) – si unisce a una specifica ricognizione attorno all’ultima edizione collettanea delle Opere varie del Cavaliere Vincenzo Monti (Milano, presso la Società tipografica de’ Classici Italiani, 1825-1827, in otto volumi) e alle sue forzate ‘lacune’ nell’età della Restaurazione austriaca, cui allude la lettera citata in esergo. In tal senso, devono essere altresì valutati scrupolosamente, anche sulla scorta degli elenchi manoscritti disponibili, i tentativi di completamento del corpus realizzati fra gli anni Trenta e Quaranta del secolo XIX, allorché la piena disponibilità degli scartafacci montiani sopravvissuti si aprì anzitutto all’attenzione e al coinvolgimento (non scevro di passioni personali) degli eredi e quindi dei loro diversi legatari. Per questa ragione, si cercherà di dare conto, seppure in sintesi, per limiti di tempo e di spazio, della formazione di alcuni dei principali fondi manoscritti oggi conosciuti, pubblici e privati (Forlì, Modena, Roma, Pavia, Parma, Trieste, Carpenedo di Mestre, Pesaro, Ravenna), senza dimenticare la rilevanza assoluta dei carteggi, sia attivi sia passivi, giustamente considerati lo strumento privilegiato per la conoscenza della letteratura italiana di fine Settecento-primo Ottocento, e da cui pour cause sono state tolte le mosse.

Leopardi e l’archivio: volontà di memoria e volontà ordinatrice
Margherita Centenari
L’archivio leopardiano ha rappresentato un campo d’indagine privilegiato per la filologia d’autore fin dalla nascita della disciplina, convenzionalmente legata all’uscita, nel 1927, dell’edizione dei Canti curata da Francesco Moroncini. Su questo primato non pesava solo il prestigio dell’autore, ma anche la ricchezza e – da una certa data in poi – la disponibilità della documentazione superstite: le carte, manoscritte e a stampa, si sono infatti conservate quasi integralmente (possediamo, per esempio, gli autografi dei tre quarti circa delle liriche della silloge, oltre alle edizioni fiorentina del 1831 e napoletana del 1835, e ad altre antecedenti, del tutto o in parte confluite nella raccolta definitiva), ma non compattamente. Quattro i principali centri di raccolta: Napoli, Recanati, Firenze e Visso; cui vanno aggiunti i più di ottanta istituti italiani e stranieri che custodiscono materiali dispersi – perlopiù, ma non esclusivamente, lettere.
Nonostante i reiterati richiami all’urgenza di una catalogazione unitaria del corpus – il primo in ordine di tempo risale al Carducci presidente della commissione ministeriale incaricata di occuparsi del lascito Ranieri alla Nazionale di Napoli, nel 1898 – solo oggi si assiste all’avvio di progetti digitali che, orientati in tale direzione, consentiranno in futuro di chiarire vari aspetti dell’archiviazione originaria, e più in generale del rapporto tra Leopardi e i suoi scartafacci.
A chi dunque intenda rintracciare nei materiali leopardiani indizi relativi alla possibile manifestazione di una volontarietà nella conservazione e nell’ordinamento delle carte si presentano vari problemi: anzitutto, la necessità di considerare i fondi attuali come entità storiche, dalla complessa e stratificata articolazione, per comprendere la quale sono indispensabili nuovi accertamenti filologici; poi quella di riunire, dove possibile e almeno virtualmente, documenti collocati in luoghi diversi ma solidali tra loro; quindi quella di definire l’eventuale pertinenza agli autografi delle opere dei materiali estravaganti (la nutrita serie di cartine e di ritagli usati per appunti, indici, elenchi, excerpta, progetti, o disegni letterari); infine, l’opportunità di leggere tali tracce materiali alla luce di alcune dichiarazioni più o meno esplicite ricavabili dal diario, dall’epistolario e da altre testimonianze. Nella prima parte dell’intervento verranno proposte alcune considerazioni sullo stato attuale dei fondi e sulla natura delle carte, con l’intento di comprendere in che misura le modalità di conservazione della documentazione abbiano inciso sulla nostra percezione del profilo dell’autore. Nella seconda parte invece ci si soffermerà sulle tracce, più o meno labili, da cui sembra emergere una vera e propria “volontà d’archivio” ascrivibile a Leopardi: la conformazione di alcuni manoscritti fa pensare sia a una volontà di preservare anche le fasi laboratoriali della scrittura delle opere, valicando spesso l’ideale cesura rappresentata dalla pubblicazione a stampa dei testi; sia a una più generale volontà di ordinamento del proprio lavoro, ispirato almeno in parte a un criterio autobiografico. La conservazione ragionata delle carte – fossero queste destinate o meno ai lettori – aveva un valore più alto per Leopardi: un valore memoriale, indispensabile alla ricostruzione privata dei propri itinerari mentali e spirituali. La storia di un’anima, insomma.

Il dominio dell’autore. Casi di autocensura nella biblioteca di Manzoni
Donatella Martinelli
Il dominio manzoniano sul proprio archivio si esercita in maniera assai minuta: l’uomo ‘nuovo’, che dopo la conversione ha impresso alla sua vita una svolta decisiva, vigila sul suo lascito, censurando le testimonianze di stagioni della formazione e della giovinezza divergenti talora dalle linee maestre della maturità. Sarà dunque quanto mai importante censire i vuoti della biblioteca: individuare i volumi del cui possesso si ha certa notizia, e che più non rispondono oggi all’appello (anche se non si può escludere la dispersione negli anni immediatamente successivi alla morte dell’autore).
Anche gli indizi contenuti nelle ‘soglie’ potranno essere preziosi, proprio perché non ‘espliciti’, e dunque meno soggetti a censura, offrendo talora tracce preziose di stagioni sulle quali l’autore ha steso il velo dell’oblio.
Resta il fatto che, mentre le carte possono essere facilmente removibili, per i libri l’operazione è più complessa. I volumi incriminati, prima di arrivare, poniamo, al rogo del caminetto (come vuole l’agiografia manzoniana), possono essere confinati in zone poco accessibili: a Brusuglio, ad esempio, dove figura tutto Goldoni (un caso di cui, in particolare, ci occuperemo).
Il campo di indagine più redditizio è dunque certamente quello dei volumi antichi, che contengono sedimentazioni complesse: i livres de chevet, che hanno segnato la formazione dell’autore, come i tomi della Grammaire di Destutt de Tracy, che accompagnano la riflessione del Manzoni a partire dai Modi di dire irregolari (1824) e durante la stesura’ del libro Della lingua italiana; o gli Elémens de Littérature di Marmontel, che rappresenta un punto di riferimento essenziale della formazione letteraria. In questo caso l’espulsione dei testimoni scomodi è problematico: quasi un doloroso distacco da compagni di viaggio con i quali è stato a lungo attivo un rapporto di speciale confidenza, e di interlocuzione privilegiata. Difficile liberarsene. Può bastare talora un lavoro di restyling: il ricorso a fitte cassature a inchiostro che rendano illeggibili le note sgradite, dissimulando magari la censura sotto la specie della correzione, del ripensamento. Pertanto, soprattutto per i volumi più antichi, sarà molto importante lo studio delle postille espunte, alla caccia delle stratigrafie più remote da decifrare, se possibile.
Nei casi estremi il Manzoni ricorre a pratiche più sofisticate: la postilla sgradita, quella che tradisce convincimenti, o giudizi, non più condivisibili, può essere sottoposta a un’opera di abrasione, cui segue un passaggio di panno umido: della scrittura resta allora come una remota sinopia che deve sfuggire allo sguardo del lettore occasionale: di chi sfoglia un libro estratto a caso dallo scaffale (ne produrremo alcuni casi emblematici). Nei casi estremi si mette mano alle forbici: qui il guasto è irreparabile. Al colpevole si direbbe assicurato l’anonimato, ma in realtà può essere individuato senza ombra di dubbio.
Nella prospettiva del nostro studio, i casi elencati vengono a costituire le prove più eloquenti di un preciso dominio esercitato dall’autore anche in zone apparentemente liminari. Il lascito di carte e di libri si deve presentare come vigilata testimonianza di una storia coerente nelle sue ragioni e nel suo sviluppo, consegnata a referti che la possano documentare compiutamente e concordemente. I marginalia dunque (questo importa) non sono affatto ‘marginali’ per Manzoni: il dialogo con i libri è stato spesso decisivo, non meno di quello con persone vive e presenti. Con un aggravante: con queste lo scambio è perduto, in linea di massima, per sempre; il colloquio con quelli invece è sempre attivo (per tracce, per segni, per parole) e pronto a rivelare qualcosa di una storia che spesso non è così lineare e univoca quanto si potrebbe credere (anzi, come deve apparire).
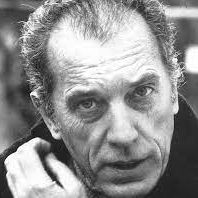
Dentro l’Archivio degli scrittori veneti “Cesare De Michelis”
A cura di SILVIA BETTELLA
coordina MATTEO GIANCOTTI
L’Archivio degli Scrittori Veneti è nato alla fine degli anni Novanta del Novecento per volontà del Professore Cesare De Michelis, in collaborazione con la Giunta Regionale del Veneto. Al primo nucleo documentario, costituito dalle bozze de La gloria del moglianese Giuseppe Berto, si sono aggiunte nel corso degli anni altre testimonianze della produzione letteraria di autori e autrici contemporanei che hanno intrattenuto un legame significativo col territorio veneto. L’Archivio si propone di raccogliere, preservare e valorizzare le carte degli scrittori, per metterle a disposizione del pubblico e degli studiosi che vogliano seguirne il percorso creativo, fatto di appunti sparsi e brogliacci, prime stesure e riscritture.
Il fondo Giuseppe Berto è, ad oggi, il più ricco e conserva materiale vario, dalle bozze delle opere alla corrispondenza con i suoi ammiratori e con personalità del mondo della cultura, tra cui Gaetano Tumiati e Andrea Zanzotto. Nel corso della sua attività, che durò fino alla morte avvenuta nel 1978, Berto spaziò dai racconti ai romanzi, scrisse opere teatrali, sceneggiature cinematografiche e articoli di giornale, e raggiunse la notorietà con Il male oscuro, in cui raccontò la sua nevrosi. I documenti del fondo sono stati curati, prima
del versamento in Archivio, dalla vedova Manuela Perroni, la quale si è occupata, insieme alla figlia Antonia Berto e all’Associazione Culturale Giuseppe Berto, della memoria dello scrittore.
Durante l’intervento saranno presentati alcuni documenti manoscritti e dattiloscritti del fondo Berto, a partire dalle carte risalenti agli anni Quaranta, quando la carriera letteraria dello scrittore prese l’avvio con la pubblicazione de Il cielo è rosso per Longanesi. Particolare attenzione sarà posta alla storia dei documenti e alle scelte conservative operate dall’autore.
